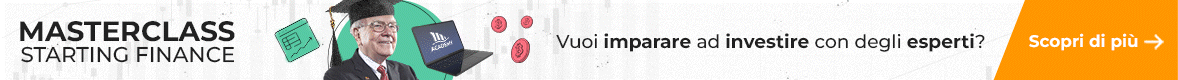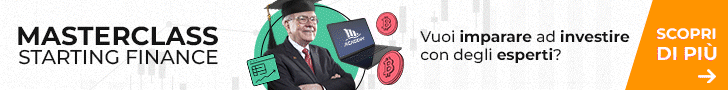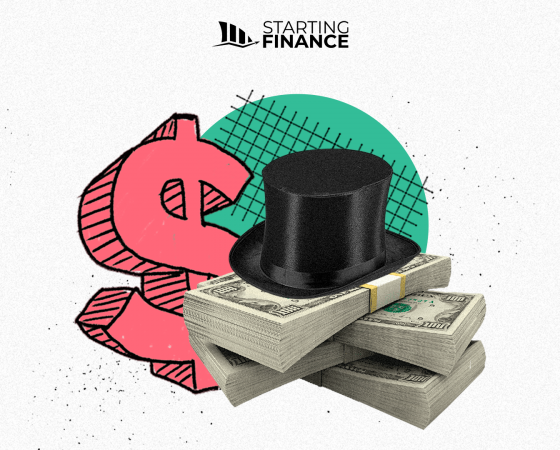Il Debito Pubblico non è altro che uno dei tanti indicatori di salute di uno Stato. Per renderlo un indicatore comparabile viene calcolato lo spread, ovvero il differenziale tra i BTP Italiani e i Bund Tedeschi. Si prendono in considerazione i Bund proprio perché sono considerati titoli a basso rischio. Essi, infatti, rappresentano lo stato di salute dell’economia tedesca che è vista come la più solida in Europa.
Più lo spread è alto e più vuol dire che il rischio default dell’Italia è crescente. Ciò può derivare da diverse motivazioni di carattere economico, politico e sociale. Uno spread più alto implica principalmente un maggior rendimento per chi sottoscrive i Titoli di Stato e si riflette in interessi sul debito più alti.
Le Agenzie di Rating valutano la rischiosità di un Paese tramite una valutazione (rating): l’Italia ad oggi viene valutata nella classe BBB (S&P), ciò implica che si trovi subito sopra la soglia del “junk rating”. Sotto il livello BBB ci sono i junk bond, ovvero i titoli spazzatura, dei titoli eccessivamente rischiosi e molto pericolosi. Recentemente Moody’s ha fatto cenno ad un possibile declassamento di rating (da Baa2, equivalente a BBB), tale declassamento implicherebbe un peggioramento delle condizioni economiche generali dello Stato, quindi anche delle banche e degli enti pubblici. Con un rating più basso, l’investitore che acquisterà titoli di Stato Italiani chiederà una remunerazione maggiore. Ciò si traduce in interessi sul debito pubblico più alti e quindi in un aumento dello stesso. Inoltre, la BCE, nell’ambito del Quantitative Easing, non può acquistare Titoli di Stato di Paesi che hanno un rating inferiore a BBB.
Di recente la BCE ha dimezzato il QE, quindi verranno acquistati meno titoli di Stato: ci sarà meno liquidità nel mercato. I tassi tra non molto quindi saliranno e i prezzi dei titoli già in circolazione scenderanno. Inoltre, quest’anno scadrà il mandato di Draghi. La sua guida nel nome del “whatever it takes”, i tassi negativi e politiche fortemente espansive hanno aiutato, tra gli altri, l’Italia a rimanere in piedi. Ovviamente, il QE non cesserà di colpo, ma diminuirà tramite un processo graduale fino a Dicembre 2018. La sua fine inevitabilmente porterà ripercussioni sui Paesi europei più deboli, tra i quali l’Italia, perché significherà un aumento dei tassi d’interesse sul debito pubblico.
Una delle possibili soluzioni è quella di ottenere un avanzo primario del 4% del PIL (differenza tra entrate e uscite della pubblica amministrazione), in modo tale da riuscire a ridurre in una decina di anni il rapporto debito/PIL di quasi il 100%. Un avanzo primario così alto non è però sostenibile nel lungo termine. Un’altra soluzione è quella di far crescere il PIL nominale in misura maggiore del costo medio del debito, strada non semplice da percorrere. Secondo i dati OCSE si prevede una crescita del 2,2% del PIL dell’Eurozona quest’anno e del 2,1% nel 2019. Per l’Italia invece, le previsioni sono di una crescita dell’1,4% nel 2018 e dell’1,1% nel 2019.
Sicuramente delle politiche a lungo termine, che impattino sulla società in generale potrebbero portare ad una crescita generalizzata dell’economia. Richiederebbe però un ribaltamento dei paradigmi e della mentalità collettiva. Servirebbe un’Italia capace di far funzionare correttamente le istituzioni e di diminuire il divario tra Nord e Sud. Insomma, un insieme di fattori sociali profondamente radicati che necessitano di una base politica solida. Quest’ultimo punto oltre ad essere il più difficile da attuare richiede anche più tempo. Servono politiche di breve, per evitare un declassamento che potrebbe portare il paese in una spirale negativa e per sfruttare l’attuale momento di assestamento dovuto alla graduale diminuzione del QE.