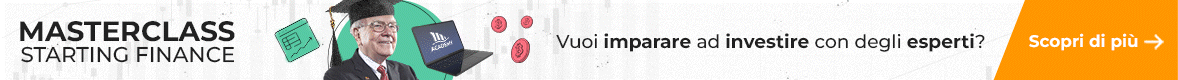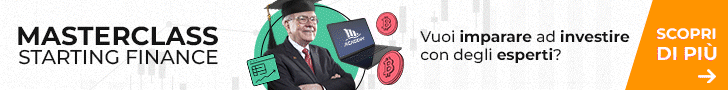Il Giappone è stato il primo Paese asiatico ad aver fatto registrare una impetuosa crescita economica, che lo ha visto affermarsi come potenza economica mondiale già agli inizi del XX secolo. Una deriva nazionalista e militarista ha poi portato il millenario impero nipponico nella Seconda guerra mondiale, durante la quale, alleato delle dittature nazi-fasciste, ha combattuto a lungo contro gli Stati Uniti per il dominio dell’Oceano Pacifico. La resa (dichiarata solo dopo che, nell’agosto 1945, due testate nucleari statunitensi furono sganciate sulle città di Hiroshima e Nagasaki) ha lasciato il Giappone completamente distrutto e militarmente occupato.
È stato proprio a partire dalla fine degli anni ’50 del secolo scorso, però, che il Paese del Sol Levante ha messo a segno i risultati più strepitosi. Infatti, il prodotto interno lordo giapponese è cresciuto mediamente del 10% negli anni Sessanta, del 5% negli anni Settanta e del 4% negli anni Ottanta e l’economia nipponica è addirittura diventata la seconda più importante a livello mondiale, dietro solo agli Stati Uniti.
Le prime flessioni
Dopo decenni di crescita ininterrotta, tuttavia, già nel corso degli anni ’80 iniziarono ad emergere le prime criticità, che avrebbero poi espresso tutti i loro effetti successivamente. Infatti il basso costo del denaro, combinato a un’elevata propensione al risparmio di un mercato interno ancora poco maturo rispetto ai fondamenti di un’economia capitalistica e consumistica, facilitò l’accumulo di molta liquidità. Per cercare la remunerazione di questi ingenti capitali ci fu una forte spinta alla speculazione in ambito finanziario ed edilizio e quando la Banca Centrale del Giappone (Bank of Japan, BoJ) provò a modificare la politica monetaria, innalzando il tasso di sconto, si ebbe un primo shock. Il crollo dei prezzi di immobili ed azioni portò al fallimento di molte banche e imprese.
A seguire, l’economia giapponese non ebbe mai una vera e propria ripresa, mantenendo nell’arco degli anni Novanta un tasso di crescita medio dello 0,8%. Quel decennio ha fatto emergere con sempre maggiore evidenza i limiti strutturali dell’economia nipponica, colpita da un’eccessiva burocratizzazione e rigidità nelle relazioni industriali e limitata da un sistema politico molto simile a quello italiano, perché profondamente permeabile alla corruzione e caratterizzato da una forte instabilità (la durata media dei governi nel secondo dopoguerra è stata di 16 mesi).
Esternamente, inoltre, si faceva sempre più forte la concorrenza delle tigri asiatiche (Taiwan, Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) che proprio nel corso degli anni ’90, dopo un lungo periodo di crescita, si affermavano come dei forti competitors sul piano industriale. In quel periodo furono molte le aziende giapponesi a traferire le proprie sedi nei quattro Paesi citati per godere della loro maggiore dinamicità economica, licenziando migliaia di lavoratori giapponesi.
La trappola della liquidità ed il quantitative easing
Fu questo il contesto nel quale il Giappone arrivò alla crisi asiatica del 1997 e alla bolla Dot-Com del 2001, che si abbatterono sul Paese del Sol Levante portandolo ad una grave recessione e in una situazione economico-monetaria teorizzata per la prima volta da Keynes negli anni ’30: la trappola della liquidità. A seguito di un lungo periodo di deflazione e debolezza economica, l’aumento dei prezzi era diventato in Giappone un comportamento socialmente inaccettabile.
Famosa, perché emblematica in tal senso, è stata la campagna pubblicitaria lanciata nel 2016 dal produttore di dessert Akagi Nyuguyo, con la quale egli si scusava per aver aumentato il livello dei prezzi per la prima volta in 25 anni. Date queste premesse si può facilmente intuire come gli strumenti di politica monetaria tradizionali in mano alla Bank of Japan fossero inefficaci.
In condizioni normali, la Banca Centrale ha la possibilità di agevolare la crescita economica aumentando l’offerta di moneta in circolazione e abbassando i tassi di interesse: le imprese sono incentivate ad indebitarsi e ad investire e contemporaneamente si riduce la propensione delle famiglie al risparmio, aumentandone la propensione al consumo.
Per uscire dalla crisi dei primi anni 2000 la BoJ fece ricorso a una forte spinta dell’offerta di moneta, portando i tassi di sconto ai minimi e facendo ricorso a un ampio programma di quantitative easing, ma i prezzi rimasero al palo e non si registrarono quindi effetti sull’economia reale. In questo caso la politica monetaria si scontrava con le aspettative di eventi negativi (come la deflazione) da parte degli operatori economici, che li inducevano ad una maggiore preferenza per la liquidità, disinnescando così gli effetti benefici della riduzione dei tassi.
L’Abenomics

Dopo molti anni però il contesto ha iniziato a mutare. Il Giappone è stabilmente tornato alla crescita economica negli anni successivi al disastro di Fukushima. L’instabilità politica è stata quantomeno momentaneamente messa da parte dalla continuativa guida del governo da parte Shinzo Abe, che è primo ministro giapponese dal 2012 e ha dato il nome alla Abenomics, un vasto programma di riforme economiche. Anche l’atteggiamento nei confronti dell’inflazione sembra stia progressivamente mutando e le aziende sentono di essere in grado di aumentare i prezzi per riflettere la qualità dei propri beni e servizi, senza doversi necessariamente scusare con i propri clienti.
Quando nel 2017 la società di spedizioni Yamato Holdings ha alzato i prezzi per la prima volta in 27 anni, essa ha affermato che le prospettive dei suoi clienti sono cambiate e la mentalità deflazionistica secondo la quale i prezzi non possono mai salire è stata sostituita dall’accettazione del fatto che talvolta l’inflazione possa essere appropriata.
I cambiamenti degli ultimi anni hanno riguardato anche l’industria nipponica, che nel frattempo si è trovata a dover far fronte anche all’impetuosa crescita dei due nuovi giganti asiatici, India e Cina. Gli investimenti sono sempre più concentrati ad accrescere l’efficienza, anziché la capacità produttiva, e pertanto la redditività data dall’impiego più efficiente del capitale viene anteposta a un’espansione delle vendite.
Si è assistito ad una specializzazione del settore industriale nelle aree in cui l’impiego della forza lavoro genera i rendimenti più elevati, come ad esempio la robotica. I margini di profitto delle aziende giapponesi sono in aumento e la loro redditività è ai massimi storici. Ciò è dovuto in parte ai cambiamenti di comportamento sopra citati, ma è anche il risultato di diversi anni di sofferte ristrutturazioni che hanno costretto le società giapponesi ad abbandonare le attività a basso valore aggiunto.
I frutti dell’apertura dei confini
La crescente apertura del Paese sulla politica dei visti ha contribuito inoltre a sostenere il boom turistico, che rappresenta una fetta sempre più importante dell’economia nipponica. Nel 2008 l’obiettivo più ambizioso era quello di attrarre 20 milioni di turisti stranieri all’anno entro il 2020, ma esso è stato raggiunto con ben cinque anni di anticipo e questo ha portato le autorità a raddoppiare la cifra, portandola a 40 milioni di visitatori entro il 2020 e a 60 milioni entro il 2030.
Inoltre si sono fatti notare effetti importanti anche nell’attrattività della manodopera estera. Infatti, benché i lavoratori stranieri siano solo il 2% del totale, nel 2017 hanno generato da soli il 30% della crescita del numero di lavoratori nel Paese. Nonostante l’invecchiamento demografico, il tasso di popolazione lavorativa attiva è in continua crescita: è arrivato al 61,4% nel 2018 e dovrebbe a breve raggiungere la stessa percentuale fatta registrare dagli Stati Uniti (63,2%), grazie soprattutto alla disoccupazione ai minimi storici e al richiamo nella forza lavoro di persone in precedenza inattive, in particolare donne e anziani.
Tutti questi fattori fanno ben sperare per il futuro, sebbene gli indicatori economici del 2019 siano altalenanti, per effetto soprattutto della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti.