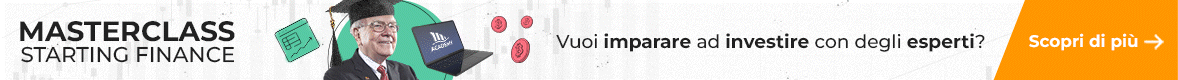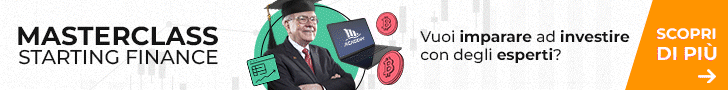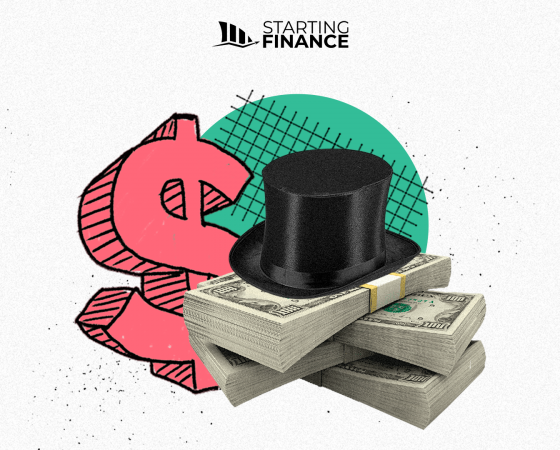Volendo aprire una dialettica incentrata sui modelli economici alternativi, la prima teoria produttiva da tenere in considerazione è senz’altro la dottrina marxiana, per sistematicità teorica come per incisività storica. Il marxismo ha influenzato le sorti del XX secolo come nessun’altra ideologia e, sebbene frustrato dal fallimento storico nelle vesti del socialismo reale, la sua coerenza teorica richiede che non vada liquidato come il lascito di un blocco culturale superato (quello sovietico), ma impone quantomeno che ne vengano svelati gli errori analitici.
A prescindere infatti da eventuali critiche ideologiche cui il modello si esporrebbe, esso rappresenta in primis una teoria di scienza economica, di cui i moderni economisti evidenziano una problematicità specifica in relazione al concetto di valore.
Valore-lavoro e uniformità del saggio di profitto
Tutta la teoria economica marxiana appare viziata dal presupposto che il valore di scambio di una merce – ciò che ne stabilisce il prezzo – derivi dal lavoro necessario a produrla. Si tratta di una concezione sostanzialistica del valore che accomuna del resto tutti i principali esponenti dell’economia classica (Smith e Ricardo compresi), e che i neoclassici aggiorneranno allacciando invece il valore del prodotto alla domanda del consumatore.
Già Ricardo era stato condotto ad un’aporia insanabile del suo pensiero dalla teoria del valore-lavoro, essendo quest’ultima fondamentalmente incompatibile con una specifica verità della scienza economica. In un sistema produttivo concorrenziale, infatti, tutti i settori produttivi assicurano lo stesso tasso di profitto (ovvero il rapporto tra profitto e capitale avanzato), in quanto qualsiasi provvisorio aumento di rendimento di un settore specifico verrebbe subito seguito dall’afflusso di nuovi capitali verso di esso, dall’aumento della produzione e dalla diminuzione del prezzo di mercato, con un effetto ultimo che andrebbe a riabbassare il rendimento settoriale verso l’uniformità del sistema.
Ebbene, questa incontrovertibile uniformità del saggio di profitto entra in ultima analisi in contraddizione con la teoria del valore-lavoro perché – solo per considerare gli esempi più intuitivi – settori diversi presentano una diversa durata dei loro capitali fissi (come la durata dei macchinari o impianti) o dei loro processi produttivi: se il prezzo di un bene derivasse univocamente dal lavoro che esso richiede per essere prodotto, allora a parità di lavoro risulterebbe più profittevole per un produttore investire nei settori con macchinari più duraturi o con processi produttivi più brevi.
Dai valori-lavoro ai prezzi di produzione
Lo stesso Marx si avvide di questa incompatibilità fondamentale, ma avendo definito il profitto capitalistico come appropriazione del plusvalore prodotto dai lavoratori, di fatto presupponeva a sua volta la teoria del valore-lavoro: fu così che nel terzo libro de Il Capitale si propose di superare questa contraddizione attraverso la cosiddetta «trasformazione dei valori-lavoro in prezzi di produzione».
Considerando che in Marx la composizione organica del capitale sarebbe il rapporto, nel capitale investito, tra capitale costante e capitale variabile (ossia come gli investimenti vengono ripartiti tra mezzi di produzione non umani – macchinari, materie prime – e forza lavoro umana – i salari), quanto a questa composizione l’economista tedesco riconobbe la variabilità dei settori produttivi. La diversa quota di forza lavoro comporta a rigor di logica che i vari settori producano diverse quantità di valore-lavoro, ma prevedendo la dottrina marxiana che il profitto origini solo dal lavoro sfruttato, ciò dovrebbe a sua volta comportare un diverso saggio del profitto nei vari settori.
Inaspettatamente però ciò non accade, in quanto per Marx i valori-lavoro prodotti settorialmente si trasformano in prezzi che non li rispecchiano a livello immediato. Ciò significa che i settori che investono più in salariati da sfruttare (dunque con una minore composizione organica del capitale) producono più plusvalore e vendono i loro prodotti a prezzi minori del valore-lavoro contenuto in essi; al contrario, i settori con maggiore composizione organica vendono a prezzi maggiori di quanto dovrebbero.
Se dunque a livello microeconomico, a causa delle ovvie variabilità settoriali nella composizione organica, il valore-lavoro prodotto non sembra combaciare col valore di scambio (o prezzo), ciò non accade a livello aggregato, in quanto il plusvalore si limita a migrare dai settori dov’è in eccesso verso i settori in cui è in difetto. Il saggio del profitto rimane infatti uniforme perché, attraverso i prezzi compensatori, chi sfrutta e produce di più vende a meno, mentre chi produce meno (perché investe più in macchinari che in lavoratori da sfruttare) deve vendere a più.
Le incongruenze
La soluzione di Marx risulta tuttavia insoddisfacente ed il sostanzialismo del valore-lavoro incontrovertibilmente ascientifico. L’argomentazione dimostra infatti una certa circolarità nel momento in cui, per ridefinire i prezzi riconducendoli ai valori-lavoro, l’economista disegna una dinamica in cui i prezzi sono di fatto già presupposti.
L’output della produzione (i beni venduti, i quali danno il profitto) è giustamente considerato in termini di prezzi, ma l’input (il capitale investito e la sua composizione organica) è visto in termini di valori-lavoro: è ovvio tuttavia che anche all’inizio della produzione gli imprenditori, quando prima di investire calcolano prima di tutto il loro profitto atteso, stimano anche il capitale avanzato (l’input) in termini di prezzi (il prezzo dei salari, delle materie prime, dei macchinari, tutto presente da subito nella stima imprenditoriale che avvia la produzione).
È quindi impossibile che il saggio del profitto ed i prezzi siano derivabili dal solo valore-lavoro (come se esso esistesse sostanzialmente), in quanto il capitale avanzato (formalmente necessario a calcolare il saggio del profitto e dunque necessario nello schema di Marx) è sempre già regolato sui prezzi.