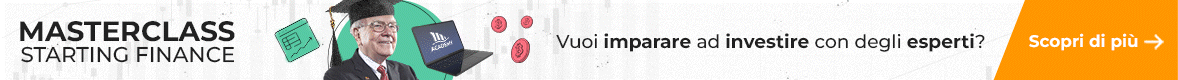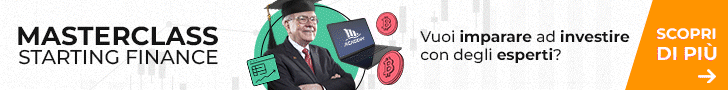Negli ultimi 50 anni gli Stati Uniti hanno visto un vertiginoso aumento della popolazione carceraria, rispetto al quale, nonostante il disinteresse generale dell’opinione pubblica, gli accademici non hanno smesso di interrogarsi. Sebbene infatti il senso comune ingenuamente leghi l’espandersi dello stato penale a funzioni di contenimento criminale, gli studiosi che affrontano strutturalmente il fenomeno hanno individuato nessi con il mondo economico-finanziario che hanno dato adito a più di una teoria interpretativa.
Alla fine del 1972 il censimento annuale della popolazione carceraria presentava 326.000 detenuti tra prisons e jails, con un tasso di incarcerazione di un cittadino ogni 625; l’anno successivo ha inaugurato tuttavia una tendenza intensificatasi soprattutto a cavallo degli anni ’80. Nel 1985 una popolazione carceraria di 750.000 detenuti raddoppiava infatti i parametri iniziali, avviando un trend di incremento annuo dell’8% che è durato fino al 1995, data in cui il censimento segnava 1.600.000 elementi. Il 2008 ha visto il picco assoluto di 2.300.000 reclusi, con un tasso di incarcerazione di un abitante ogni 133.
In meno di 40 anni, dunque, la cifra di riferimento iniziale è aumentata quasi del 700%, un incremento folle ed eguagliato solo dall’aumento di spesa pubblica necessario a sostenerlo; si è passati infatti da 7 miliardi nell’80 a 70 nel 2007.
Il prison industrial complex
I menzionati trend quantitativi hanno presto destato l’attenzione accademica, soprattutto alla luce del fatto che in questo arco di tempo il tasso di criminalità ha oscillato tra 4 e 6 crimini annuali ogni 100 cittadini in maniera assolutamente indipendente dal trend di espansione penale, smentendo ipso facto chiunque sostenesse le finalità meramente repressive delle prigioni.
Constatata, al contempo, la sovrarappresentazione di poveri e neri nella popolazione carceraria, i sociologi hanno presto individuato nell’iperincarcerazione una specifica strategia repubblicana nel confronto col problema della povertà. Questa criminalizzazione della miseria è derivata dunque in prima istanza da ragioni politico-elettorali; tuttavia, stando alla teoria più invalsa in ambiente accademico, quella del prison industrial complex (PIC), sono gli interessi economici che gravitano intorno al mondo carcerario a fornire le ragioni profonde del fenomeno.
I teorici del PIC riconducono l’enorme incremento della popolazione carceraria al cosiddetto complesso carcerario-industriale, un intreccio tra istituzioni politiche e grandi gruppi industriali nel quale le prime alimentano artificialmente l’isteria collettiva nei confronti del criminale (che per antonomasia è povero e nero) per giustificare un’espansione dell’apparato penale di cui giovano poi le seconde.
I politici, da parte loro, favoriscono l’iperincarcerazione con inasprimenti penali ed incrementi di budget per una serie di ragioni: oltre all’attività di lobbying che subiscono, la loro retorica di tolleranza zero nei confronti del crimine deriva dai menzionati scopi elettorali e soprattutto dal tentativo di trasformare il povero da elemento socialmente destabilizzante, se libero, a fonte di ricchezza e occupazione quando viene messo dietro le sbarre. Tuttavia ciò che viene vigorosamente sottolineato è che questa dinamica non sarebbe possibile senza gli interessi corporativi che avvolgono il mondo carcerario.
Interessi corporativi nell’espansione carceraria
L’edilizia carceraria rappresenta il primo di essi, in quanto dalla fine degli anni ’70 l’incremento nel numero dei detenuti ha comportato la necessità di costruire sempre più istituti. Questo bisogno si è risolto, nel tempo, sempre più spesso con l’appalto ad imprese private, in virtù degli accorciati tempi di realizzazione e dell’eliminazione per lo Stato dei costi di acquisto del terreno.
Altrettanto competitiva risulta poi la gestione privata delle carceri, grazie alle minori garanzie economiche che le imprese offrono ai propri dipendenti, con tutto l’abbassamento degli standard di professionalità che ne deriva.
Dai 16.000 detenuti rinchiusi nei penitenziari privati nel 1995 si è passati a 93.000 nel 2000 e a quasi 99.000 nel 2004, con una forte espansione nella diffusione di questi istituti, che da pochi Stati iniziali è arrivata a coprirne ben 28. L’attività risulta particolarmente lucrativa in quanto il governo federale o statale e le contee finanziano il mantenimento e la sorveglianza dei detenuti risarcendo gli istituti privati di circa 20-22.000 dollari annui per unità.
Le società coinvolte
Le società che intercettano la quota maggiore di questo mercato, circa il 77%, sono la Corrections Corporation of America (CCA) e la Wackenhut Corrections Corporations (ora GEO Group), entrambe multinazionali che operano anche nel Regno Unito ed in Australia; tra il 1996 e il 1997 esse hanno aumentato i propri introiti rispettivamente di 169 e 72 milioni di dollari: risulta ovvio, dunque, che esse hanno tutto l’interesse che il tasso di incarcerazione continui a crescere.
Lo stesso vale anche per le imprese che forniscono alle carceri beni e servizi: è proprio tramite questa fornitura che avviene il maggior trasferimento di denaro pubblico nelle casse delle multinazionali. Si spazia dai beni alimentari alla comunicazione, fino all’assistenza sanitaria, per un flusso di capitali talmente ampio che, rifornendo queste società anche le prigioni pubbliche, la distinzione tra carceri private e statali perde di importanza. Solo per quanto riguarda i nomi più conosciuti, tra questi rifornitori possiamo citare Nestle Food Service, Polaroid, Hewlett-Packard, Verizon ed AT&T.
Gli effetti sulla popolazione carceraria
Va menzionato poi lo sfruttamento privato del lavoro dei carcerati: quest’ultimo rappresenta infatti una fonte di lavoro a basso costo, allo stesso modo del lavoro non sindacalizzato dei Paesi del Terzo mondo, rendendo il suo utilizzo una paradossale forma di delocalizzazione su suolo nazionale.
Nel 1996, all’apice della sua attività produttiva, la Boeing Corporation scelse di massimizzare i profitti riducendo i posti di lavoro in patria per ricercarne in Cina, dove vigeva il divieto di riunirsi in sindacati e gli stipendi arrivavano a 50 dollari mensili. Parte della forza lavoro, però, venne reclutata anche presso il riformatorio statale di Washington: la Microjet, che costruiva parti di aeroplano per la Boeing, assunse i prigionieri dell’istituto in una fabbrica costruita e mantenuta gratuitamente dallo Stato. Nel ’97 i lavoratori carcerati percepivano meno di un quarto della paga oraria di quelli liberi, anche se il maggior vantaggio per le casse della società derivava dal risparmio sull’assistenza sanitaria e sui benefici di disoccupazione.
Testimonianze analoghe forniscono la Lockhart Technologies, Inc. e l’Omega Pacific, che chiusero le rispettive fabbriche ad Austin e Redmond (Washington) per trasferirsi in istituti correzionali.
I costi sociali
Seppur molto bassi per le imprese private, tali stipendi rappresentano per i detenuti un’enorme opportunità rispetto alle occupazioni statali come la pulizia o la mensa, finendo per fomentare una competizione sfrenata che li mantiene sui minimi previsti dalla legge. Questi minimi vengono oltretutto osteggiati proprio dalle stesse imprese, in una folle corsa al ribasso per il costo del lavoro: esse sostengono infatti che un maggiore sfruttamento di questa nicchia di mercato occupazionale comporterebbe una diminuzione del costo pubblico della detenzione, il quale sarebbe supportato invece dallo stesso detenuto-lavoratore. In realtà, ciò che viene taciuto è che a beneficiare di un eventuale abbassamento sarebbero per prime ovviamente le imprese stesse.
Altro fattore da tenere in considerazione è infine l’investimento di società finanziarie nei titoli emessi da quelle aziende sopra elencate: si tratta di un meccanismo derivativo che tuttavia, proprio per questo, svela la pervasività delle logiche imprenditoriali, spesso invischiate nel citato prison industrial complex.