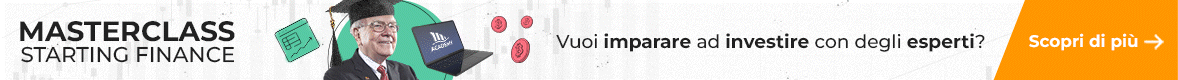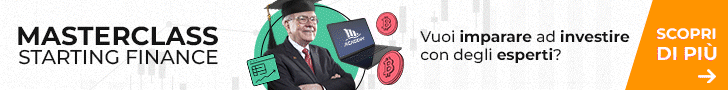“Free-to-play”, “pay-to-play”, “pay-to-win” e “freemium” sono solo alcuni esempi di quella complessa nomenclatura usata ormai quotidianamente in ambito videoludico per descrivere l’infinita serie di giochi per console o per cellulare e di applicazioni di varia natura a cui siamo abituati. Raramente ci si sofferma a riflettere su quanto rapida sia stata l’evoluzione del suddetto settore negli ultimi decenni: si è trattato di un salto tecnologico dalle incredibili potenzialità, capace di apportare enormi miglioramenti alla qualità del gioco e all’immedesimazione del giocatore all’interno dell’ambiente virtuale. La sopracitata crescita, al contempo, ha però incrementato l’interesse delle grandi aziende del settore verso le nuovi fonti di lucro che si andavano via via creando con questi nuovi mezzi. Spinte a ricercare metodi di guadagno più interattivi rispetto al classico “compra il gioco in negozio, vai a casa e divertiti”, le aziende si sono rinnovate radicalmente sviluppando strumenti innovativi e più funzionali.
Numerosi sono i sistemi ideati dalle case-madri per rendere possibile questo nuovo tipo di commercio e, sebbene alcuni di essi, free-to-play e freemium in primis, siano assai simili, le diverse sottocategorie che si possono avere possono comportare sistemi di monetizzazione differenti. Ma cosa si intende per free-to-play? Suddiviso a sua volta in giochi “puri”, “ibridi” e “impuri” (termini derivanti dalla più o meno elevata simpatia dei players nei confronti dell’equità offerta dal gioco), esso consiste nel vendere veri e propri servizi alla persona per accelerare i tempi di gioco o per modificarne l’aspetto estetico. Costruito sul sistema delle cosiddette microtransazioni – nome usato per indicare movimenti di denaro di bassa portata – e volto a garantire la gratuità del gioco base per accattivare l’interesse del pubblico, il free-to-play cela in realtà un acuto sistema di guadagno realizzato attraverso implementazioni o capacità potenziate offerte dietro l’acquisto di pacchetti dal costo variabile che consentono all’acquirente di migliorare notevolmente le proprie prestazioni all’interno del gioco. Differenziandosi da altri mezzi di monetizzazione quali i «DLC» e le «espansioni», che come obiettivo primario hanno quello di modificare l’ambiente di gioco, le microtransazioni, portando armi, personaggi potenziati o “loot box” (scatole del tesoro), sono capaci di alterare in maniera quasi assoluta l’evoluzione del giocatore.
Chi, scaricando una qualsiasi applicazione dal mercato mobile, non si è mai imbattuto nelle “gemme” o nei “diamanti”? Questi oggetti, descritti come la soluzione a qualsivoglia problema all’interno del gioco, sono spesso il vero strumento con cui gli sviluppatori delle app rientrano degli investimenti fatti e del tempo speso a creare il gioco, ricavandone anche una buona percentuale destinata ad essere il proprio guadagno personale. Possiamo dunque ritenere dovuta la spesa da compiere nel caso si voglia migliorare la qualità del gioco selezionato. Se ci addentriamo ulteriormente nell’ambito è necessario evidenziare, però, quanto i potenziamenti acquisiti siano poco utili ai fini pratici dell’ambiente di gaming, poiché essi hanno come unico scopo quello di accelerare la normale durata dell’esperienza ludica vissuta dalla persona e di sminuire le difficoltà proposte dagli stessi sviluppatori.
Offrendo margini di guadagno così elevati, dati dalla velocità con cui al soggetto risulta possibile effettuare l’acquisto, è chiaro che la situazione spinga le aziende leader del settore ad un utilizzo talvolta soffocante del metodo. È necessario però sottolineare anche quanto gli introiti da microtransazioni siano un ottimo trampolino di lancio per startup che decidano di muovere i primi passi in settori complessi quali quelli dell’hi-tech e degli store online. Offrire prestazioni maggiorate dietro compenso è, quindi, un buon punto di incontro tra le richieste dei giocatori di migliorare le proprie abilità e la possibilità degli autori di soddisfare questa domanda.
C’è però un problema. Alcuni publisher che sfruttano le microtransazioni per monetizzare sono spesso attaccati da fiumi di critiche proprio per il loro obiettivo di base: quello di rendere eccessivamente semplice, per non dire noiosa, la stessa esperienza di gioco. La ragione di quanto detto deriva dal fatto che se nell’ambito singleplayer vedere una precoce accelerazione delle proprie capacità senza un reale progredire del contesto di gioco non implica conseguenze particolari, in uno multiplayer la supremazia di colui che ha acquistato potenziamenti sarà pressoché assoluta e incontrastabile da parte di quei giocatori che si limitano ad un’esperienza senza spese. Recentemente, ad esempio, la società statunitense Electronic Arts ha ricevuto ampie critiche riguardanti “Star Wars: Battlefront II”, gioco per console uscito a novembre, nel quale l’acquisto di pacchetti tramite microtransazioni per sbloccare alcuni personaggi principali sembra rappresentare l’unica alternativa alle estenuanti ore di gioco monotono necessarie per il loro sblocco gratuito; la preoccupazione principale del pubblico è che un sistema di acquisti di questo genere rappresenti una “tassa” nascosta imposta ai giocatori per godere pienamente dei videogame di fatto già pagati (Star Wars: Battlefront II, infatti, non rientra nella classe dei free-to-play e, come tutti i giochi per console, va acquistato).
Si evidenzia così la necessità di affrontare un ultimo problema di fondo, assai più pericoloso ma momentaneamente irrisolvibile: la dipendenza che si può creare dall’acquisto dei suddetti pacchetti. Nota la semplicità con cui è possibile entrare in possesso di questi potenziamenti e la loro relativa economicità, è chiaro che soggetti psicologicamente meno consci dei rischi derivanti da un’incontrollata facoltà di acquisto siano più propensi a sviluppare dipendenze patologiche dal gioco, in una nuova forma di ludopatia.